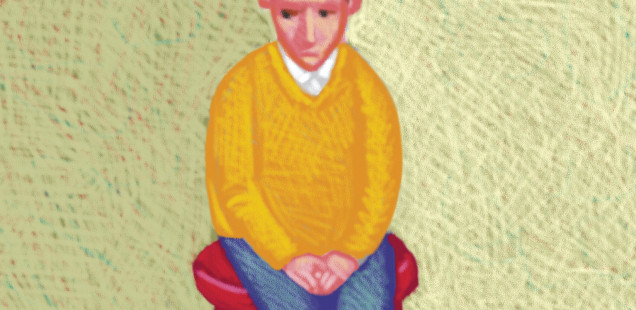
“La scuola degli idioti” di Marco Onofrio, spiegata “a scuola” da Palmira De Angelis
“La scuola degli idioti” di Marco Onofrio, spiegata “a scuola” da Palmira De Angelis.
Se dovessi presentare o introdurre questi racconti di Marco Onofrio a un pubblico di giovani lettori, ecco, la prima cosa che direi è: “state attenti, non è semplice. Accostatevi con circospezione e procedete piano, non ingozzatevi, perché Onofrio potrebbe saziarvi subito: non bevete tutto d’un fiato, perché non solo vi potreste trovare inebriati e incapaci di intendere, ma potreste perdere quel gusto che arriva alla lingua e al palato solo se ci si sofferma ad assaporare ogni sorso”. Trattandosi di Onofrio, una similitudine con il mangiare e il bere sembra peraltro ben adatta, e già parto con il piede giusto, come insegnante, senza tradire il mio autore. Poi – questa è la prassi che in genere si segue a scuola – dovrei contestualizzarlo all’interno di una tradizione letteraria, in accordo o in contrasto con essa. Già mi pare di sentire qualche studente che butta là qualche battuta: «è vivo, è contemporaneo, e meno male!» «Sicuro che è contemporaneo?» dice un altro. «Io ho letto alcuni pezzi» – pezzi, non passi, dicono i ragazzi – «e questo Onofrio usa un sacco di parole che non ho mai sentito, anzi: me le sono appuntate, eccone qualcuna…. “perfezion”, così tronca; “da lunga pezza”, “imbandigione”, “giulebbe”, “fondiglio”…» «Non solo» lo interrompe un altro «io mica ho capito se è prosa o poesia, ho avuto la sensazione che se spezzassi le frasi e andassi a capo verrebbe fuori una specie di poemetto… è come se avesse scritto il testo di una lunga canzone, si sente dentro una specie di melodia… ma non è che è un paroliere?» Insomma, frizzi e lazzi. A questo punto devo interrompere. Riprendo in mano le redini: Marco Onofrio, sì, è vivo e nostro contemporaneo. Con molti di noi, credo, questo scrittore condivide la sfiducia che la vita possa avere una qualche forma, una qualche coerenza, uno scopo che non sia quello di riprodursi, caotica e leopardianamente ostile, nemica ai deboli, collusa con gli avidi, i disonesti, i prepotenti. Una vita tanto tollerante con ciò che è brutto e squallido, quanto irridente di ogni sforzo che il singolo possa fare per abbellirla, renderla più giusta, meno feroce.
«Leopardi, il singolo, l’individuo, la vita matrigna: professoressa, non sarà che questo Onofrio è un neo-romantico?»
Ci sono ragazzi perspicaci a scuola: anche se non possiedono strumenti critici raffinatissimi, qualche volta ci azzeccano con l’intuito. Però fuochino, fuochino. I protagonisti di questi racconti sono in effetti persone sole, individui schiacciati, isolati, inermi, vinti, anche rancorosi per essere messi sempre in un angolo. Tentano di ribellarsi, provano ad attaccare, ma restano sempre incapaci di uscire da una situazione che li imprigiona in un ruolo di “scarti”. Però questa situazione non sembra un assoluto, non è la leopardiana Natura con l’iniziale maiuscola, e l’individuo non è “tutti gli individui”, ma proprio questo individuo “qui”, che vive vicino a noi, cammina per le nostre strade, va a braccetto con la propria donna, siede all’ultimo banco di una classe di idioti. Questo individuo debole, confuso, angosciato e reietto è il prodotto della nostra società. Una società, peraltro, ormai totalmente urbana, in cui la natura non è madre né matrigna: proprio non c’è, è assente, o, se la si incontra, è nella forma estranea di un maiale riverso sulla strada degli umani, che impaurisce, disgusta, repelle, e infatti lo si vuole eliminare.
«Vuol dire, professoressa, che Onofrio nei suoi scritti critica la società?»
Sì. Onofrio punta il dito contro l’immoralità, la crudeltà e la bruttezza della società contemporanea. La fa non solo in questi racconti, ma anche nelle poesie e nelle altre prose, dove il tessuto della narrazione è sempre quello della denuncia – valga per tutti il poemetto di civile indignazione “Emporium”. Noi siamo ovviamente i figli di questa società, divisa tra deboli e forti. Tra chi pensa e sogna e chi non pensa e guadagna, tra chi scrive bene e chi pubblica bene, tra chi si fa leccare il deretano e chi si trova ripetutamente di fronte all’amletico dilemma: leccare o non leccare? E siamo esseri soli: i personaggi di questi racconti non hanno amici, se li hanno tradiscono; non hanno un compagno: figure di amanti e fidanzate compaiono talvolta fuori o dentro un letto, ma sono sostanzialmente delle figure estranee, palliativi alla solitudine, che al massimo servono per il piacere fisico, non certo persone di cui fidarsi, a cui raccontare delle proprie preoccupazioni e della propria angoscia.
Uno studente che, evidentemente, ha letto di più, osserva: «nella sua rappresentazione del mondo in cui viviamo, Onofrio ricorda Eliot, la “Waste Land”, la Terra desolata».
Bene ragazzi, bravi, lo avete portato dall’Ottocento all’inizio del secolo scorso: Onofrio si sta guadagnando a passi lenti la sua modernità. Ma si accende ora una piccola bagarre, perché quelli più bravi entrano in competizione, e un altro contrattacca: «E no, Eliot proprio no. Niente neo-modernismo. Intanto abbiamo appena detto che la denuncia di Onofrio riguarda questa società, la nostra, che è una vera schifezza ma sarebbe perfettibile, se solo lo volessimo. Onofrio non ha intenzione di trasformare la sua denuncia in una, come si dice? mitopoiesi: non è l’individuo in quanto tale, sempre platonicamente uguale a se stesso, ma il prodotto di questa società capitalistica, oppressiva solo verso alcuni strati economici».
Non mi sentirei di censurare qui in classe un po’ di sano vecchio marxismo. Anche perché il ragazzo prosegue ricordandoci che T. S. Eliot chiama la sua scrittura “Frammenti”, ricordate? «These fragments I have shored against my ruins». Ci sono sì le rovine, ma Onofrio non ne vuole proprio sapere di frammenti: lui usa parole su parole, frasi e discorsi, come armi, come munizioni, come testuggini in movimento, divisioni, corazzate, flotte…
Devo interromperlo perché… esagera? No: in realtà sono d’accordo con il mio studente, ma ha toccato un campo che mi interessa in modo particolare e che voglio trattare io, se permettete… In fin dei conti sono l’insegnante. E così dico: è vero, parole su parole, tasselli, mattoni, cui però la voce narrante dà un’unità: quella di uno spazio chiuso, circolare, dove tutto sta dentro, equidistante dal centro, dove non c’è progressione, maturazione, svolta, e il personaggio si ritrova alla fine come all’inizio. Unità di tempo, luogo e azione: le unità aristoteliche usate a rappresentare una condizione che ricorre claustrofobica, entro cui ci si può solo dibattere scompostamente, furiosamente. Lo spazio si restringe addosso al personaggio, si deforma, attiva le sue nevrosi, rivela la perdita della capacità di comunicare. Questi luoghi, infatti, rappresentano ossessivamente la nostra civiltà degradata in cui non solo la natura è assente, e con essa il ciclo del riposo e della rinascita, ma anche la parola ha perso la sua funzione comunicativa.
L’individuo, schiacciato in tale contesto, depresso, umiliato dalle Istituzioni – scuola, chiesa, accademia – è incapace di comprendere ciò che lo circonda. Perché ciò che lo circonda ha perso solidità, oltre che senso. Ciò che il singolo vede, o patisce, può – ed è questo che accade in più di un racconto – risultare alla fine irreale, soltanto sogno, illusione, visione distorta, apparizione, nulla. Come dicevo all’inizio, per Onofrio la vita è informe, confusa, indistinguibile dalle nostre proiezioni mentali, e qualunque tentativo di “rappresentarla” non può che fallire. Il linguaggio di Onofrio denuncia questo fallimento. Addio neo-neorealismo. Abbiamo saltato e superato una narrazione fondata sulla fiducia che il linguaggio possa far vedere in trasparenza una realtà oggettiva – sociale o psicologica che sia –, e che il narratore, facendo un passo indietro e nascondendosi dietro il proprio dito che indica, possa distogliere lo sguardo del lettore da sé e indirizzarlo su ciò che viene indicato. No, Onofrio non procede per via di sottrazione, per frammenti, silenzi, nascondimenti della voce narrante; Onofrio rilancia. La sua è una concezione glottocentrica. La parola, in questi racconti, si impone con una grandezza e una potenza che ne riducono la funzione comunicativa a un ruolo complementare all’altro suo ruolo, quello puramente estetico: diciamo fifty fifty, perché Onofrio è bene attento a non pendere dalla parte dell’estetismo puro. Così il linguaggio non è un mezzo per descrivere la realtà, bensì è la realtà stessa; non è lo specchio del mondo esterno, ma è il mondo nella sua dimensione di sogno/incubo/scrittura. Una scrittura che inevitabilmente si frappone tra chi narra e ciò che è narrato. Una scrittura che vuole essere protagonista e attirare attenzione. Ecco, questo è il mio dito, altrettanto interessante della cosa che indico. È un elemento vivo, che libera pulsioni sue proprie. È il trionfo dionisiaco della parola, l’affermazione di un “soggettivo” che si impone come unico modo di rappresentare una realtà che ormai non è più nemmeno liquida, è fantasma evanescente e forma precaria. Il linguaggio, in questo libro di racconti, chiaramente dispiegato come costruzione fittizia – scarsamente denotativo, se per occasionali, rapide cadute di essenzialità semantica – procede per accumulo di associazioni e assonanze, e segue una musicalità precisa, ben orchestrata, una sorta di onda melodica – forse aveva ragione il ragazzo che faceva di Onofrio un paroliere.
Ponendosi, la parola, di fronte all’informe, al vuoto, essa tenta di sfuggire all’abisso con il gioco, e diviene così affabulazione ridondante, colorata, brillante, pirotecnica: uno spettacolo che inventa di volta in volta le proprie regole, il proprio lessico, andandolo a pescare magari in vecchi libri dai fogli ingialliti, rilegati a mano col filo, o nei bar delle periferie, per poterti sorprendere quando si rivela arma puntata contro le brutture del mondo. Come dicevi tu prima? parole che sono divisioni, testuggini in movimento, corazzate, flotte…
Insomma, dobbiamo ammettere che in una scuola, non di idioti, qualcosa di Marco Onofrio – non tutto, certamente, ma qualcosa – oggi si è capito.
M. Onofrio, “La scuola degli idioti”, Roma, Ensemble, 2013, pp. 140, Euro 15.
