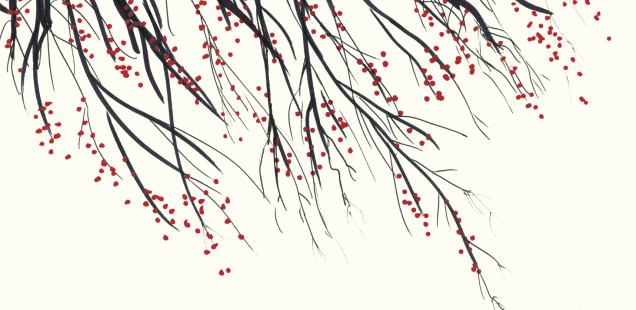
«Come una storia d’amore» di Nadia Terranova
Recensione di «Come una storia d’amore» (Perrone, 2020) di Nadia Terranova. Articolo di Nicoletta Bortolotti.
Non tutte le scritture hanno il medesimo modo di passare sul mondo e ricrearlo, ma tutte, o quasi, hanno origine da un medesimo luogo di assenza, disincanto, non mare. Una faglia di dolore dalla cui magmatica oscurità trabocca, a tratti, felice, la filigrana di una narrazione, il petrolio denso e amaro che la fatica dei secoli consolida nel tetraedro di un cristallo.
Anche i magistrali racconti collezionati in una sorta di antologia delle ombre, ultima opera dell’autrice di quel capolavoro che è Addio fantasmi, in cinquina al premio Strega, ideale prosecuzione, forse, dell’assorto e bellissimo Gli anni al contrario, non fa eccezione.
Figure umane, vivide, ma anche dalla carne appiattita dei simboli, inquietano fughe, desideri, amori, disamori, illusioni, tagli, sul palcoscenico di queste pagine, dove la letteratura, la lingua che ne espone il camminare, il divenire, il rincorrere, il disperare, è indicibile e autentico sottotesto di una saudade che può trovare la via della voce solo quando si scrive di loro. L’unica voce spessa come una radice che veste di senso la nebulosa del pensato. Una voce in prima persona, più omodiegetica che autobiografica, e che talora necessita di imparare una lingua “altra”, l’ebraico, nella quale “ogni parola contiene una radice biblica, epocale, rovinosa, eppure piena di luce.”
Teresa che pilucca fra i banchi del mercato e a cui l’ictus ha strappato tutti i nomi; i corvi che strepitano nel “quartiere di appartenenze” dove un lui e una lei, “macchie di non appartenenza” cercano casa; una sorella (la sorella?) che costeggia il panarium, monumento funebre di un antico fornaio romano, come il cimitero delle proprie aspirazioni artistiche consumate in un lavoro in pizzeria senza il conforto dell’elegia; il ferroviere in pensione, vedovo che, dopo la perdita della moglie, appare come “attraverso una radiografia, senza un polmone”…
Biografie tratteggiate a spigoli di luce e nicchie d’ombra, icone di una malinconia stoica nel suo cedere al fatum, al letterale latino “ciò che è stato detto”, dell’età adulta, quando si comprende che “il mondo non ha il dovere di occuparsi della nostra felicità”. Biografie di dolenza dove la pietas dell’autrice è anche pietas per se stessa.
E poi c’è un altro luogo, la cui voce narrante s’impone senza poter essere tacitata, Roma, o in una nomenclatura più segreta e privata R., poiché la letteratura, quando assolve bene al proprio intento, rende a chi legge prima di tutto un paesaggio, una topografia interiore e dell’immaginario, dove ritrovare o smarrire la longitudine e la latitudine del proprio sé.
La Terranova possiede la rara perizia di inabissare nello spazio e nel tempo di una città eterna alla ricerca di una nuova eternità e di una nuova lingua. E, per bizzarria, la lingua meno logora e più futura è l’ebraico, appreso alla scuola del ghetto, “unico caso di lingua morta e poi risorta di cui ho notizia, e paradossalmente appartiene a un popolo che non crede nella resurrezione.”
Ma di Roma, museo metropolitano e archeologia del dissepolto, quasi la Storia stessa nella sua interezza fosse condannata a ripetersi e subisse il destino di una damnatio memoriae, città in un’altra città, l’autrice sa soprattutto, come ogni grande narratore, raccontare la luce: “stronza”, “forsennata”, “fanatica”, una luce “che se ne frega delle stagioni e celebra un’eterna sagra all’aperto”.
Questa Roma popolare (e impopolare), viva e violenta, termini che condividono la medesima radice della forza vis, più che rimandare alla Lisbona di Pessoa, assorta nelle sue raffiche di luce vuota, nella metafisica controra della Baixa, riconduce al quartiere San Lorenzo della Storia, dove Iduzza (fra l’altro anche il nome della protagonista di Addio fantasmi, forse in omaggio alla Morante) s’immerge tra le bancarelle dei fruttaroli, tasta la polpa violacea della materia vivente in una melanzana, vaga ingannando il tempo nel ghetto, negli avamposti di un giorno della memoria che dura tutti i giorni (“quella data non ha bisogno di me, sebbene io ne abbia di lei). E così Via del Portico d’Ottavia, piazza Mattei, la fontana delle tartarughe, la Reginella tracciano un personale e vivente atlante della Shoah dove, per paradosso, si può cercare la montaliana e sempre elusiva felicità raggiunta: “In un settembre esageratamente triste mi ero messa in testa di studiare due cose: l’ebraico e le persone felici”. Questa Roma riecheggia la Roma pasoliniana dei Ragazzi di vita, l’orizzonte senza orizzonti delle periferie, assolate e desolate, perché il sole quando eccede muta nella propria assenza. E la Napoli, forse, di Elena Ferrante, tragico e claustrofobico labirinto che ci costringe alla perenne ricerca e alla viscerale nostalgia di una madre smarrita. E proprio come i rioni di quella Napoli, nel principio della quadrilogia, sono senza mare, i quartieri di questa Roma sono senza fiume.
Grande assente presente, luogo di tutti i luoghi, è il Tevere, il flumen Albulus, che non compare, ma lo si percepisce scorrerci accanto come un nastro trasportatore di millenari rottami. Si percepisce la sua acqua in cammino, che senza mai svoltare a una verità, si trascina un mobilio confuso e senza gerarchia di corpi, oggetti, battaglie, sconfitte.
Il Tevere va avanti e anche questa Roma è andata avanti, mescolandosi con altre geografie o recuperando una geografia più arcaica, prebarbarica, e insieme postmoderna: africani, bengalesi, le cui lavanderie fanno concorrenza a quelle indigene, ne popolano i quartieri, re magi vestiti oggi di umiltà che però tornano da una grandezza, dalle provinciae alla periferia dell’impero che lo resero potente.
Nadia Terranova compone per il lettore una guida turistica del passato e del futuro, sedotta da una tristezza, e qui il richiamo a Pessoa è d’obbligo, non apertamente dichiarata. Più un mood, una scia melodica, una rapsodia in blues, un refrain in là minore che ne cuce insieme i capitoli. Fino all’ultimo.
La narrazione dell’amore, che ne attesta l’esistenza (“l’unica è raccontarsela”), ne cattura il suo nascere dove non può nascere niente (la stazione Termini) e il suo morire dove non può morire niente (“all’inizio nessuno pensa che pure quella parola, amore, si esaurirà”). Proprio come Roma anche l’amore è una città eterna finché dura e di cui bisogna inventare un nuovo linguaggio. E, forse, viene da chiedersi se la città che l’autrice vuole togliersi di dosso con un coltello, non sia Roma, ma il disamore, di cui l’urbe rappresenta solo le quinte sfatte, con la sua grande bellezza decadente e in agonia.
Dicono che gli autori comici o di commedie siano creature tristi, e viceversa, gli autori che sanno scavare la dolenza siano creature leggiadre. Nadia Terranova indossa una sua caustica ironia che le fluisce a volte nel sorriso, quasi a tradimento, come la fioritura dei mandorli della sua Sicilia. Ma sempre nel fondo con il là minore della sua Sicilia quando il mare sullo Stretto incupisce.
Perché leggere adesso, subito, come una storia d’amore. Per la scrittura. Il libro ha uno stile asciutto, ma incalzante, che procede per urgenti folgorazioni, e i personaggi propagano onde emotive fino alla profondità del sangue. Per il coraggio del bravo editore e scrittore Giulio Perrone che, in questa pandemia senza pubblico, ha pubblicato tale gioiello, peraltro con una bellissima e calligrafica copertina, quasi in stile nipponico, dove sono i vuoti a raccontare i pieni.
Per i luoghi. Oggi che il corpo si è ammalato e recluso, distante dai luoghi, la mente si affolla di luoghi dove siamo o non siamo stati. E noi senza viaggio troviamo in queste pagine un viaggio. Senza vaccino troviamo il vaccino della bellezza. E l’arte, questo libro, che avevamo dimenticato nel territorio dell’inconsistente, consiste.
© Nicoletta Bortolotti

