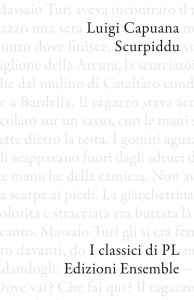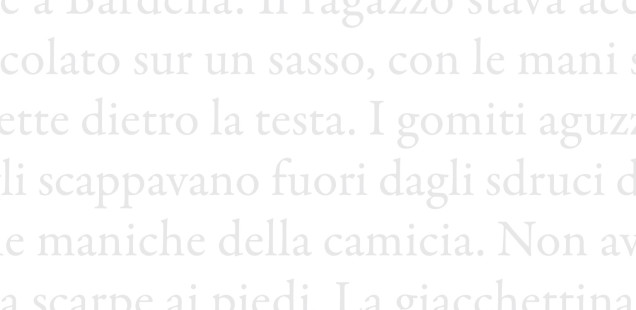
“Scurpiddu” di Luigi Capuana. Dall’Arcadia alla Belle Époque: un “romanzo di formazione” nella Sicilia rurale
Spunti da “Scurpiddu” di Luigi Capuana.
Destinato “non […] soltanto ai ragazzi”, ma certo elettivamente a loro, Scurpiddu, il breve romanzo di Luigi Capuana appena ripubblicato da Ensemble (la prima edizione è del 1898), si presenta essenzialmente come un Bildungsroman: e questo, nonostante che le sue dimensioni asciutte – correlativo oggettivo, verrebbe da dire, della adolescenziale magrezza del protagonista allusa dal soprannome, che significa “sterpo, ramo secco”, forse con qualche eco del dantesco “perché mi scerpi?” di Inf. XIII, 35 – contraddicano la teutonica corposità che alla definizione sembra idissolubilmente connettersi.
Nè si può evitare, leggendo, che sul protagonista si allunghi l’ombra del verghiano Rosso Malpelo (1878, poi in Vita dei campi, 1880), con cui il ragazzino protagonista condivide la condizione di sfruttamento minorile (benché in un plein air di maliose tinte paesistiche, ben diverso dai cunicoli cupi della zolfara!), quella di orfano – qui, di padre, prima che di madre -, ma non, ed è ciò che più conta, la tragicità quasi di ghost story su cui il testo di Verga si chiude.
Perché se proprio la kastrophè da tragedia era stata uno degli aspetti unificanti delle brevi, acuminate narrazioni di quella raccolta verghiana (infrangendo così uno dei più rispettati precetti del canone classicistico, quello per cui, Aristoele dixit, i protagonisti della tragedia sono sempre e solo “re, regine, personaggi illustri” del mito o – ma questo solo da Roma in poi, e nel Rinascimento – della storia, e da cui ci si aspetta che si esprimano in stile sublime, e in versi, preferibilmente), nel racconto di Capuana al tragico si sostituisce il più sereno modello dell’Arcadia: dichiarato, per altro, fin dalla prefazione, in un richiamo esplicito al conterraneo, anche se di lingua greco-dorica, Teocrito e ai “gai e giovani Egipani” del mito, con tanto di zampogna al seguito.
Così è già dal capitolo inziale, che si conclude con la citazione del virgiliano cadere della sera mentre il fumo si avvolge alto dai comingoli delle masserie di Buc. I, 83; e anche, a ingannare le ore vuote del suo lavoro di nuzzaru (le capellae di Titiro sono infatti sostituite da più anacronistici tacchini: e tacchine, con i conseguenti episodi di insperata nascita di pulcini, e innesco su di essi delle incipienti velleità imprenditoriali del loro giovanissimo guardiano…), il ragazzo si confezionerà un flauto di canna, suonando il quale, quasi novello Orfeo, non si trascinerà certo dietro animali e uccelli, però ne imiterà alla perfezione i richiami, e, descritto con affettuosa minuzia dall’autore, perfino uno strumentino per poter duplicare il frinire delle cicale.
Poi, con più profonda diversificazione ideologica, nei Malavoglia (non sfugga il simmetrico ricorso al soprannome dialettale, che in Capuana però non è ironicamente antifrastico, ma scherzosamente asseverativo) l’impatto di ‘Ntoni, al momento dell’odiato servizio militare, con la grande città del continente, scintillante di luci e popolata di, un tantino vampiresche, donne che vi si aggirano nelle loro vesti a strascico, era stato l’inzio della caduta, quasi l’inoculazione, nell’intimo del suo ingenuo ceppo popolano, di una distruttiva infezione, quella cupidigia capitalistica, nume ispiratore dell’invisa civiltà piemontese che a Verga ormai, a vent’anni di distanza dai furori patriottici dei primi romanzi, dichiaratamente ripugna. Nel racconto di Capuana, invece, (il cui protagonista, intanto, si offre un episodio di entusiastica metamorfosi in arigiano di coroncine, con ottimo riscontro di mercato) le città del Nord – conosciute per mezzo di un libretto propagandisco-educativo che il ragazzo riceve in dono, e che a noi fa venire in mente certe Odi e inni del Pascoli più caduco – si caricano di attrattive tra il fantastico e il pedagogico, con i loro “bei monumenti!” e le “magnifiche chiese!”.
Ma è, ben diversamente che in Verga, soprattutto il miliarsimo, la divisa dei bersaglieri, “polverosi, sudati, ma altieri, con le piume al vento” come in una tavola di Beltrame, il suono delle trombe, a caricarsi in Capuana di un preciso significato ideologico; non solo uno dei comprimari del romanzo, il Soldato appunto, “era stato bersagliere, e quelle trombe lo eccitavano”, ma anzi, simpateticamente, “Scurpiddu si mise a camminare in cadenza allegramente, eccitato pure lui”, e quello di arruolarsi diventa per il protagonista, che ormai ha deposto, all’uscita dall’adolescenza, la sua eponima malnutrizione infantile (“veniva su diritto come un fuso, mingherlino, ma forte e ben fatto”), oltre che un obiettivo ideale (“l’idea di andar soldato gli ribolliva nella fantasia dal giorno che aveva visto i bersaglieri. Voleva vedere un po’ di mondo, come tant’altri, “E a spese del re”, soggiungeva”), proprio l’approdo conclusivo della sua Bildung.
Nell’explicit del romanzo, quello che per tutta la narrazione non era stato altro che Scurpiddu (o, al più, nelle pagine iniziali, Mommo) “diventava SCAGLIO GIROLAMO nel 3° reggimento bersaglieri, 1A compagnia”: avviandosi così, è lecito pensare, a quel “Mestiere di ammazzar la gente e farsi ammazzare” pesantemente svalutato dal parroco (“se fossimo cristiani davvero, ci sarebbe bisogno di soldati?”), in un sogno idealistico – e, ancora una volta, pascoliano! – di concordia ordinum: “ognuno sarebbe contento dello stato in cui Dio l’ha fatto nascere, e si vivrebbe in santa pace”.
Siamo, dunque, ben lontani dall’Arcadia iniziale: e se proprio Titiro non è diventato Eurialo o Pallante, certo si sente benissimo l’atmosfera entro cui, fra qualche anno, deflagrerà l’immane macello che la morte, nel 1915, impedì a Capuana di conoscere.