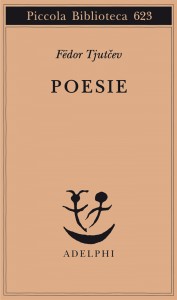“Poesie” di Fëdor Ivanovič Tjutčev. Un primordiale ardore.
Lettura del volume “Poesie” di Fëdor Ivanovič Tjutčev edito da Adelphi.
«Schönheit also ist nichts anderes, als Freiheit in der Erscheinung»
La Bellezza altro non è che la libertà nel fenomeno
F. Schelling
Dentro te celi tutto un mondo
d’arcani, magici pensieri,
quali il fragore esterno introna,
quali il diurno raggio sperde:
ascolta il loro canto – e taci!
«Silentium!» Tjutčev
Ritrovino le mie labbra, recuperino
la mutezza lontana, primordiale,
simile a una nota di cristallo
che vibra, fin dal suo nascere, pura.
Silentium, Mandel’štam
Ai suoi versi si ispirò Osip Mandel’štam per la citata poesia Silentium (Osip Mandel’štam, Ottanta poesie, a cura di Remo Faccani, Einaudi 2009). Se è vero che gli scrittori russi, al pari dei trovatori medievali, sono cultori del richiamo evocativo ed intertestuale, è notoriamente risaputa la loro originalità. Nel caso di Tjutčev sorprende la sua sensibilità visionaria, e gli aspetti più sotterranei e trepidanti della sua poetica lo identificarono già come precursore del simbolismo. Il nostro poeta anticipò un’epoca, vivendo la propria, l’ottocento romantico, il periodo forse più florido della letteratura russa, pervaso da un clima di vigore creativo che porta i nomi di Puškin, Lermontov, Žukovskij. Tuttavia Tjutčev non partecipò alla vita letteraria – alcune sue poesie furono pubblicate nel 1836 con le sole iniziali “F.T.” su «Il contemporaneo», rivista fondata dall’autore de La dama di picche – e questo probabilmente spiegherebbe perché fino alla metà del secolo il suo nome non fosse noto al pubblico. L’Adelphi, mercé una recente edizione (2011), lo ripresenta nella traduzione di un altro grande poeta e scrittore italiano quale fu Tommaso Landolfi, confermando l’assunto secondo cui i poeti sono i traduttori dei poeti, generando nell’incontro un’affinità capace di cogliere il respiro del verso individuando e cercando di recuperare, per quanto possibile, l’evocazione analoga della lingua originale o ricreandola daccapo nella lingua di arrivo. Dalla versione landolfiana emerge un sentimento intenso e travolgente, calzante con gli stati d’animo dell’autore.
Di Tjutčev risalta, da quanto ripeschiamo dalla tradizione critica italo-slava, la cadenza retorica e solenne ispirata all’ode settecentesca (Mirskij, Storia della letteratura russa, Garzanti, 1965, p. 139-142), ma con un impianto di versi attraversato da una tensione metafisica, vibrazioni suggestive da una parte con vertiginose ascese verso l’alto e dall’altra con discese nella dimensione onirica. Colpisce per lo scorrere sotterraneo della parola che raggiunge esisti di naturale bellezza e di luminosità inaspettata:
Il passaggio dal classicismo al romanticismo, sotto l’influenza in parte di Žukovskij, ma prevalentemente del contatto diretto con la poesia romantica tedesca, è una decisa affermazione del tono lirico. Da una parte si sente l’influenza di Schiller di cui il poeta traduce, rielaborandolo, L’Inno alla gioia, dall’altra quella del Lamartine e anche del sentimentalismo inglese del Gray. A queste esercitazioni o esperimenti del proprio spirito poetico, se ne aggiunsero poi altri con le traduzioni di Goethe, Heine, Byron, Herder, fino a che il poeta sentì in sé la capacità di affidare tutto se stesso, nel senso di dare espressione poetica ad una propria concezione del mondo.
(Ettore Lo Gatto, Storia della letteratura russa, Sansoni, 1964, p. 285)
Suo riferimento filosofico fu Schelling, al quale è possibile correlare la personalissima Weltanschauung del poeta. Ma il «dominante intellettuale» dell’idealismo estetico fu figura referenziale anche per altri poeti coevi – le figure di Schelling e Goethe esercitarono un’influenza palese presso Baratynskij – soprattutto se si considera che Schelling postulava un ruolo fondamentale per l’artista, in particolare per il poeta il cui dovere, ci ricorda Colucci (Evgenjij Baratynskij, Liriche, Einaudi 1999, introduzione p. L), era di portare bellezza e verità. Purtuttavia, la poesia di Tjutčev non è assoggettata alla sola concezione idealistica, ma dischiude un universo vitale e sfolgorante:
Arcano, come il primo dì del mondo,
arde nel cielo senza fondo il coro
degli astri, s’ode musica lontana,
prossima fonte mormora più chiaro.
[…] (p. 42)Oh come la fumata in alto splende
e scorre inafferrabile, giù, nell’ombra!…
«Ecco la nostra vita – mi dicesti –
non il fumo brillante nella luna,
ma quest’ombra dal fumo rifuggente…»
[…] (p. 71)
Prescindendo per un momento dai temi propri del poeta – il Caos e il Cosmo, la riflessione metafisica, le antitesi significative volte in scenari impressionanti (per es. il velo dorato dell’alba e l’abisso della notte) – si avverte un inquieto ardore che è un tratto rappresentativo, non solo in senso romantico, della sua scrittura:
D’un tratto tutto si turbò: un convulso
fremito corse i rami dei cipressi,
la fontana si tacque, ed un bisbiglio
strano sonò indistinto, come in sogno.Cosa fu questo, amica? O non invano
la trista vita, ahimè, che in noi correva,
la trista vita col suo inquieto ardore,
varcato aveva la segreta soglia?Villa italiana, Dicembre 1837 (p. 63)
Nei suoi versi tale ardore lo sentiamo combinato a qualcosa di primigenio, di originario, la parola poetica sembra riacquisire un senso primordiale e mitico. Simili illuminazioni di significato prorompono a tratti come sprazzi rapsodici:
Oh non cantare questi orrendi canti
tu, del caos antico, del natale!
(p. 51)
o in una cadenza continua e verdeggiante:
Dall’inverno, lo stregone,
incantata, sta la selva;
sotto là l’immota e muta
frangia della neve, brilla
di meravigliosa vita.
(p. 102)
È una discesa, una meditazione capace di carpire il silenzio dell’esperienza umana e trasportarla in un linguaggio magico e trascendente:
Pur nella nostra vita quotidiana
si dànno di iridati sogni:
in magica regione, in mondo ignoto,
a noi straniero ed intimo ad un tempo,
siamo d’un tratto trasportati.
(p. 114).
In altre parole, Tjutčev ci racconta, ci indica un’esperienza che sta fuori dal tempo, nascosta nella nostra vita e nella nostra interiorità, e pur se non riusciamo talvolta a strappare il velo del fato perché «le fatali parole non son chiare» (in questo pare rievocare la Sibilla), questa regione ignota emana bagliori «come quando uno spirito ci parla».
L’intuizione mitica e originaria non è assente da altri poeti russi a lui successivi. Nel Viaggio in Armenia del citato Mandel’štam (a cura di Serena Vitale, Adelphi, 1988) si legge:
Scavarono una profonda trincea intorno all’albero. L’ascia si abbatté sulle indifferenti radici. Il lavoro del taglialegna richiede perizia. I volontari erano troppi. Si davano da fare intorno all’albero come inesperti esecutori di un’infame sentenza.
Io chiamai mia moglie:
«Vieni a vedere, ora cadrà».
E intanto l’albero resisteva con la forza di un essere pensante – sembrava che avesse completamente riacquistato la coscienza. Disprezzava i suoi carnefici e i denti da luccio della sega.
(p. 30)
e oltre, in una sua poesia dedicata alla lingua armena:
E amo la tua lingua di presagi
sinistri, le tue giovani tombe
dove ogni lettera è tenaglia,
ogni parola – uncino.
(p. 114)
in cui la coscienza del poeta si unisce alla percezione dell’albero che viene abbattuto e nella forma grafica della lingua armena. L’occhio di Mandel’štam è un occhio avido nel catturare immagini, e «una forza imperiosa lo spingeva a guardare al “romanzetto del presente” da una prospettiva antica, remota.» (postfazione di Serena Vitale, p. 177).
La vertigine rivelatrice della parola poetica trova una definizione profonda presso Iosif Brodskij, il quale nel suo saggio Fuga da Bisanzio scrive a proposito dello stesso Mandel’štam:
L’arte non è un’esistenza migliore, ma è una esistenza alternativa; non è un tentativo si sfuggire alla realtà, ma il contrario, un tentativo di animarla. È uno spirito che cerca la carne, ma trova parole.
(p. 72, a cura di Giovanni Buttafava, Adelphi, 1987)
In definitiva sentiamo preponderante e incontrovertibile non tanto l’affinità presente nei poeti sopraccitati – l’affinità resta sempre l’anima dell’intertestualità – quanto un linguaggio poetico comune e ardente, la cui finalità tende alla riconquista di un archetipo significativo che è alla base dell’evocazione, di quel mormorio antico che sta nel fondo della parola:
Sì, pure istanti sono
di cui non si può dire:
son benedetti istanti
di terreno abbandono.
(p. 110)
Mormorio consonante con la natura in Est in arundineis modulatio musica ripis:
È nell’onde marine melodia,
armonia nelle zuffe d’elementi,
e ben temprato, musicale fruscio
tra gli ondeggianti giunchi corre.Costante accordo in ogni cosa,
piena nella natura è consonanza:
sol nella nostra libertà illusoria
disaccordo con essa ravvisiamo.Tal disaccordo donde, come?
E perché mai nel generale coro
non canta il cuore ciò che il mare,
e leva voca la pensante canna?
(p. 127)
in cui il poeta afferra «l’oscura radice dell’esistenza del mondo» (Solov’ëv) e raggiunge ciò che Elémire Zolla definirà nel suo Archetipi (1994, 2005) come «l’esperienza metafisica», esperienza di cui la parola è ombra e mistero.
Fëdor Ivanovič Tjutčev (1803-1873) visse a lungo in missione diplomatica (1822-44) in Germania, dove conobbe F. W. J. Schelling e H. Heine. Un gruppo di 16 poesie furono pubblicate sul Sovremennik fondato da Puškin. Turgenev curò un’edizione delle sue liriche (1854). Del 1868 è la prima raccolta completa, Stichotvorenija (Versi). Con la nascita del movimento simbolista Tjutčev fu riconosciuto il maggior poeta del secolo dopo Puškin. In Italia fra i suoi curatori e traduttori troviamo Eridano Bazzanelli, Ettore Lo Gatto, Angelo Maria Ripellino e Renato Poggioli.
ARTICOLO ORIGINARIAMENTE APPARSO SU POETARUM SILVA