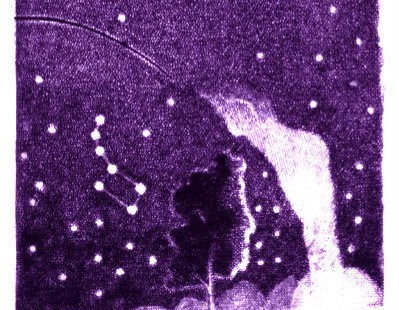
Breve riflessione su alcuni possibili rapporti intercorrenti tra Natura e Poesia
Il rapporto che intercorre tra Natura e Poesia è talmente solido, radicale ed ancestrale da consentire un numero infinito di rimandi ed intercorrenze.Tuttavia vale la pena forse di notare come la Natura non muova vettorialmente alla Poesia, ma la Poesia – dalla radice greca di ποιέιν: fare, quale atto creativo e reinterpretativo del reale – assuma la valenza archetipa di elemento di “interferenza” e “tangenza” di quel sistema perfettamente atto alla progressione degli eventi, che spesso definiamo come Natura.
La capacità di interferenza infinitesimale cui di solito gli uomini equiparano il loro volere o il loro agire, assume – nell’accezione creativa del segno che abbatte la prima categoria del Sistema-Natura, cioè del Tempo – la dimensione dell’intervento di correzione dell’agire umano capace di autodeterminarsi al di fuori della ripetitività naturale (cioè naturante e naturata) dell’atto, veicolandosi verso una dimensione transindividuale cioè comunicativa.
Natura e Poesia, cioè a dire Cultura, non vivono però tra loro determinandosi solamente quali poli antitetici del Vero umano: sono anche biunivoca dipendenza della determinazione del Sentire dell’Uomo, e quindi – in questa determinazione della forma e maniera percettiva – della autopercezione della Umanità quale entità metaindividuale, permettendo agli Uomini di svincolare il senso ultimo della realtà sistemica in cui Tutto muove dai contenimenti contingenti; ed attraverso ciò compiendo il più alto degli atti culturali: quello cioè dell’autoriconoscimento del Sé e del Gruppo dei propri Pari/Umani quali parti ed a un tempo alterità rispetto al complesso degli esseri e delle forze che orbitano attorno.
Nella esperienza umana, la Natura è tuttavia, indubitabilmente, innanzitutto percepita come Alterità.
Il dialogo continuo dell’Uomo col Mondo diviene in questa ottica, uno specchio scissorio dell’esperienza poetica che si presenta, nell’ambito di questo rapporto complesso, come il celebre bastone di Popper: uno strumento di avvicinamento del Vero-Altro-Natura, ma non un modo assoluto di conoscenza perché sempre determinato dall’ unicum/unum esperienziale dell’Osservatore-Individuo.
Esiste, in questo elemento di irriducibilità, forse uno degli elementi principali della fascinazione emulativa esercitata dalla Natura sull’Individuo e, in particolar modo, sul Poeta .
Il percorso umano, costante, continuo della ricerca del Sé nell’Altro, appare lungo questo tragitto di “Creazione-RiCreativa”, privo di soluzione di continuità pur nella sua peculiarità temporale.
Sia che la si intenda quale complessità di elementi, che quale apparizione epifenomenica, la Natura appare all’uomo “poiente” un monito irraggiungibile; un mistero non sondato perché non sondabile; una chimera allettante perché foriera di infinite ed incontrollate possibilità.
È, in altre parole, il mistero del Sé come Creatura Cosciente, punto d’intersezione tra lo stato di Natura e quello ontologico ed identitario di autoindividuazione, di Cultura.
L’identità scissa della modernità emerge forte lungo la dorsale di questa faglia: come nella leopardiana perdita delle illusioni, l’Uomo trova lo Spazio ed il Tempo esterni a lui, ma a lui interiormente ed esperienzialmente avvinti, irriducibili ad una identità Io-Mondo, Dentro-Fuori tipica invece della poesia classica.
Addirittura, mi azzarderei di pensare l’esperienza della Follia, presente in tanta parte di certa letteratura ed arte ( quali quelle sudamericana e russa del Novecento, ad esempio) frutto di questa Coscienza-Percezione profonda di una Naturalità indomita e immutabile che avvolge condiziona e ingenera il Vincolo nel quale muove l’universo dell’agito e del desiderato umano.
La Natura è, nella nostra individualità moderna, ostilità altera; al più, titanico sforzo; illusione amara; spunto di individuazione del Vulnus creaturale che ci attanaglia.
Come in un tempo senza controllo, sta lo scoprirsi dell’individuo centro di un’esperienza umana senza centro.
Lo smarrimento della non comprensione di una esperienza contingente frutto di una logica sistemica a-temporale perché pre-temporale, pone la questione della logica che la sottenda: una a-logicità che si dovrebbe a questo punto definire pre-logicità.
Siamo forse, in questo punto esatto dell’osservazione, di fronte alla constatazione che il naufragio postmoderno del pensiero dell’occidente è e può essere esso stesso, un atto anfotero di distruzione e di rifondazione del pensiero e -forse- di rinvenimento delle impreviste vestigia di ipotesi di reimpostazione di una qualche tradizione metafisica.
Come in una nuova alba paleolitica, non la pietra scheggiata, ma la capacità umana in essenza della trasformazione del Vero, è, il senso stesso dell’affronto individuale –come anche collettivo e di specie – al sistema Mondo Storia Universo Altro.
Un affronto prometeico che, con sintesi esatta, la nostra radice più classica chiama POESIA.
Se, come figura della Natura quale Sistema che ogni evento umano, non umano e meta-umano incardina, assumessimo infatti un asse cartesiano con le sue direttrici classiche X, Y e Z -dove l’asse X delle ascisse rappresenti il Tempo, quello Y delle ordinate lo Spazio e il terzo asse la variante umana- ci accorgeremmo che c’è, nell’inevitabile infrangimento tridimensionale dell’alloggiamento fenomenico delle nostre osservazioni, uno spirito vero di ri-creazione della realtà come artificio che però così si fa – in se – vera realtà: realtà-artificio percettivo e realtà-artificio creativo – comunicativo.
Nella quarta dimensione dell’asse cartesiano nel quale contestualizziamo il nostro agire infatti, assumiamo noi stessi, animali di natura, una valenza paradossale di Creatori/Creativi/Creati.
Questo scontro tra i due respiri dell’Uomo, pone l’interessante dilemma di quale identità possegga in se questo nostro agito: non prescindendo dal contesto del sistema assiale, esso rientra pienamente nella categorie del naturale (in quanto Naturato), ma nel contempo poiché si basa sull’assunto individuale e metaindividuale del Soggetto, infrangendo il postulato di identità oggettiva che ogni fenomeno di natura porta in sé stesso quando prescinda dal contesto speculativo dell’Uomo, pur mantenendo una propria collocazione nel Sistema-Natura, pone se stesso come una ipotesi alternativa alla presunta oggettività naturale del Reale (pone sé stesso cioè come Naturante).
A mio giudizio, oggi muove da queste considerazioni ed esigenze una tendenza ben individuabile della poesia contemporanea occidentale.
Si tratta di un pensiero che si ritrova speculativo in sé, ma anche nella contestualizzazione dell’Io Poetante poiché naturale; e contrappone la propria esperienza speculativa a quella dell’avanguardia più recente che ha pensato ed in parte ancora pensa il Fatto poetico come mera denuncia della perdita di un Senso.
Nella mia esperienza di scrittura, credo di aver tentato di esprimere questo concetto attraverso una silloge intitolata L’Attraverso (Roma, Ulisse Editrice, 2004): la storia per l’appunto di un attraversamento possibile del limite ontologico creaturale che ci trattiene al fondo del vero senza impedirci di sapere che però esiste una misura di verità non trovata, ma necessaria alla sopravvivenza della speranza di senso della multanime umana che, sincronicamente e diacronicamente, esprime richiami e rimandi di fratellanza, sforzi di identità.
La prima fase di questa ricerca si è venuta delineando principalmente attraverso l’utilizzazione di una personale modalità linguistica: nella netta decostruzione della parola intesa come luogo dell’identità oggettiva del Vero, sono stati inseriti degli elementi di reinvenzione che valessero quali ingranaggi aggiuntivi nella successiva ricostruzione per acquisirne una significazione di funzionamento.
Le parole, come iperbole a mezz’aria, vogliono tradurre uno stupore di incompiutezza.
Nella forza inesorabile ed iconoclasta in cui questa osservazione costringe il verso, frattanto, una decostruzione della versificazione genera accenti intensi, sottolineando il silenzio come vera μνήμη del senso, come accidente riflessivo. E, su tutto, un elemento di natura che è, in se, non solo contesto, ma evento: linguistico, concettuale, spazio-temporale, emotivo.
Un vero Evento di Senso da cui partire o ritornare non conta, perché unico fondale – non solo golfo mistico- dell’azione poetica.
Ad esemplificazione di quanto detto, si potrebbe consultare la poesia “Natura riprende” tratta dalla raccolta sopra citata:
Natura riprende
Natura Riprende
Ciò che Altrui
è Segnato
Sovrasta Struttura
del seme d’Adamo
È edenica
Mela
di caos e nomos
Ristretti
Nel nulla sapere accertato
:Oltregiorno
che vieni
Risciolto a Ritardo.
Stigmàta Attenta
Innegata,
sragionata
Saggezza :
Distrutto ramo e nuovo
su Tempo Sentiero.
Anche ad una prima sommaria analisi della composizione emergono chiaramente i vari elementi evidenziati: l’infrangimento della versificazione, comportando una spazializzazione del foglio diffusa, dilata come nell’esperienza della semina (v. 5) i diversi accidenti verbali (id est le trasfigurazioni delle parole) pronti ad effettuare una muta verso una ipotesi di verità mentre, su tutto, aleggia l’idea di una Natura “Sragionata” (v. 18), cioè al di fuori della casualità ragionante umana che, come una mano, sorregge la scatola-contesto della speculazione dell’Uomo portatore di segno (v. 3). Questa impossibilità di riduzione ad oggettiva Verità è la Dannazione (v v. 7, 8), lo scontro della creatura col suo limite rispetto alla inattuabile volontà (v v. 8-11) di porsi come discrimine tra comprensione ed insensatezza (v. 9). È il Segno (v. 17) di questa impossibilità, l’infamia (giacché neppure negata) sostanziale (v. 18) di una credibilità e significatività priva di ragione: essere cioè accidenti naturali (v. 22) lungo la direttrice pulviscolare del tempo (v. 23).
Vastissimo è il numero di coloro che penso vicini a queste posizioni, e percorre febbrile l’intero Novecento occidentale; su due poeti in particolar modo però vorrei soffermarmi per esemplificare rapidamente quanto sostenuto: Andrea Zanzotto e Gëzim Hajdari.
Il primo, notissimo, e dall’innegabile valore artistico ed umano in quanto portatore di una rinnovata humanitas, ripropone e puntualizza intelligentemente (cioè con nuovo desiderio di intelligibilità), lo snodo del linguaggio come strumento di ricerca e come essenza (ma anche negazione dell’essenza in quanto trasmissibilità assoluta e condivisibile) di verità. Seppur la sua scrittura complessa, coltissima e cerebrale potrebbe talvolta apparire non aderente all’interrogativo dell’Uomo rispetto alla Natura, il suo cammino di dialettico oggetto (da ob-iăcere: scagliare fuori, contro…) verso l’impenetrabilità dell’Altro; la sua verbosità barocca in una reificata prigione di parole, che trasforma in pietra il mondo attraverso l’immobilizzazione del linguaggio quale impalcatura intorno ad un nucleo tragicamente vivo e pulsante che tenta i suoi lacerti di speranza nella costruzione di (impossibili) ponti comunicativi e metaindividuali; tutto ciò pone in maniera magistrale la sua opera e la sua ricerca nel vulnus esatto, nella crepa del rapporto dialettico tra Sé e Altro (dove l’Altro -varrà forse la pena di ripeterlo –in quanto alterità, rappresenta lo specchio creaturale, la medesima attribuzione di appartenenza insondabile attribuibile al Sé).
Anche alla luce di numerose interpretazioni ed interventi di molti e autorevolissimi studiosi, come i celebri e preziosi studi mengaldiani (specie in PIER VINCENZO MENGALDO, La Tradizione del Novecento, Torino, Einaudi-Bollati Boringhieri, s.d.), o quelle di Agosti (in modo particolare penso al bel saggio introduttivo dal titolo L’esperienza di linguaggio di Andrea Zanzotto in ANDREA ZANZOTTO Le poesie e prose scelte a cura di S. Dal Bianco e G. M. Villalta, Milano, Mondatori, collana Meridiani, IV ed., 2000); e ancora all’apporto di F. Baldini (Zanzotto dalla Heimat al mondo, idem), due raccolte su tutte sentirei di poter segnalare a supporto di queste mie poche parole di riflessione:IX Ecloghe (1962) e Beltà (1968). Senz’altro riduttivo sarebbe indicare una singola composizione o una sola di entrambe, ma offrendo un estremo quanto inutile sforzo potrei azzardarmi a suggerire la lettura in IX Ecloghe di “Un libro di ecloghe”, in cui l’alterità è una “ipotesi leggente” (v. 2,), così come ipotesi sono le variazioni di “13 settembre” che chiude tra fila di punti sospensivi in una parentetica riaffermazione del verso iniziale: componimento nel quale l’unica strofa estranea alla litania variante chiude nel suo quarto verso infrangendo quella divergenza tra Sé e Mondo come soggetto di arrivo ed oggetto di partenza dello sforzo speculativo e reinterpretativo dell’impossibile (a dirsi!) Vero: scritto che autentica questo suo pensiero nell’apposizione privativa invertente la fisionomia dell’originario soggetto della luna- dove la “luna puella pallida” è evidente citazione del verso “animula vagula blandula”dell’imperatore Adriano, citato in calce all’ecloga IV. Questa volontà oppositiva del linguaggio prescelto non solo – nella confusione che è specchio del clima epistemologico e filosofico nel quale è maturata la scrittura – determina ed evidenzia il pensiero di impossibilità come di immobilità del Poeta, ma neutralizza la vastità temporale, diacronica, della portata poetica e pure, in ciò, nuovamente la anima. Così come reifica la cecità di “Appunti per un ecloga”, citata per allusione al decimo verso, ma che si fa comunque linguaggio (v. 1: lo “pseudo braille”,) in tutti gli interventi degli alter ego che si alternano ad a (soggetto esperienziale): persone foriere di alterità in-possibile, ma sempre in forma di codici e linguaggi (“Sempre in bilico tra Lirismo e Scientificità”, dice in una sua celebre affermazione Mengaldo) come “convenzione/prima in cui il tutto si rifà ragione” (vv. 11-12, ).
Molto toccante è poi la trama e l’ordito di rimandi che Zanzotto intesse nella scrittura della raccolta Beltà (1968): in una ripresa holderliniana e rilkiana (“Siamo un segno senza significato” v. 12 in “Sì, ancora la neve”,idem; o “Orfico non è quel grumo di nomi” v. 1 in “Possibili prefazi o riprese o conclusioni”, idem) non meno che dantesca in alcune variazioni e riscritture, emergono due apici emotivi di grande rilevanza rispetto alla natura di questa disquisizione: innanzitutto il bellissimo, già citato “Holderlin: «Siamo un segno senza significato»:/ma dove le due serie entrano in contatto?” cioè l’esplicitarsi di un interrogativo che impalcava tutta la produzione precedente ma che qui assurge ad una urgenza esistenziale fortissima e che, nel consueto gioco degli opposti zanzottiano, passando per il silenzio come parsimonia, come sonno, come sospensione del giudizio e dell’interpretazione nella superba poesia “Alla stagione” giunge anche al naufragio nell’immortalità dell’unità dialettica tra Sé e Altro attraverso l’uso di un linguaggio -seppur non declinato (in quanto si fa esplicito cenno all’uso dell’infinito: cfr. ultima strofa verso conclusivo della parte terza): la delineazione poetica di IX Ecloghe sfiora così l’altro momento a mio avviso irrinunciabile della raccolta, cioè le due strofe conclusive e il verso di chiusura della quinta sezione di “Possibili prefazi o riprese o conclusioni” in cui il naufragio dell’io interno e fuso con la vicenda del mondo (ancora Agosti) non azzarda più alcuna interpretazione eppure pare porsi nel mezzo di quell’ interstizio di silenzio (il sonno, la parsimonia) tra i due ineguali emistichi del verso conclusivo.
Straordinariamente diverso eppure incredibilmente vicino, appare, all’universo di Zanzotto nell’ombra di qualche inaspettata piega della sua fisionomia, quello di Hajdari.
Poeta difficile, aspro, lirico ed espressionista ad un tempo, capace di ricordare Rilke quanto Trakle passando per la più alta tradizione dei grandi Americani e degli Italiani (da Pascoli a Leopardi non disattendendo Dante), il poeta bilingue che nel 1992 giunse dall’Albania in una Trieste allucinata e comunque non troppo dissimile da quella della raccolta “Trieste e una donna” del Canzoniere di Saba (“Quando sbarcai al porto di Trieste” in Stigmate, Nardò (LE), Besa Editrice, 2006), Hajdari canta un esilio non solo reale (tema centrale principalmente di Spine nere, Nardò (LE), Besa Editrice, 2006; e ancor più in Stigmate,cit.) ma anche un esilio mistico dal mondo intero inteso come totalità, appartenenza. Con un moto incredibilmente vicino al più autentico Leopardi, incentra la sua scrittura intorno a luoghi “di natura” la cui bellezza e grazia struggono il suo sentimento di Verità, di irriducibilità ad unità, di inassimilabilità ad un sistema di giustizia umana e metaumana (cfr. ad esempio “Belle giornate squarciate nelle colline di Darsia” in Stigmate, cit.): riecheggiano di un sentimento di natura leopardiana, ma riletto in un attesa epifanica molto rilkiana, numerosissime composizioni della superba silloge Maldiluna (Nardò, Besa Editrice, 2005); e su tutte la lirica “Ritorna dal tempo al tempo” (ivi) capace di dilatarsi nelle “stanze sgombre” che disseminano la sua intera produzione, e di trovare apici di emersione nei rimandi, quasi shenal, a nomi totemici, a piante simbolo (su tutte la ginestra di “Rientrando in ciociaria in pieno maggio” in Stigmate, cit.), mai dimenticando un mondo avicolo che però già sfuma in una citazione pascoliana di matrice psicoanalitica (“Una psicologa della padania” in Spine nere,cit.; e fr. 49, 51-55 di “La rosa canina” in Maldiluna, cit.).
La sua poetica esplode in un linguaggio che è – come in Zanzotto – il vero cardine di una impossibilità: lo struggersi davanti all’alterità sottendente ogni suo componimento. Alterità questa, capace di assumere i tratti di una natura cruda, raramente idillica se non per contrasto; una natura ostile, feroce, nera come gli uccelli neri che – da semplici merli del ricordo –lo forniranno di una veglia del ritorno; una natura che è femmina, che è antitesi tra nord (Italia; luogo che accoglie) e sud (Albania; ciò che si e ci abbandona), ma che è anche madre, in una bestemmia continua ben più grave di quella pasoliniana per ricostruire il senso di una verità impossibile (si pensi alla strofa-epilogo toccante di “Maldiluna” nella raccolta omonima), in cui l’affronto del senso impossibile della verità, l’infrazione della Besa (“parola data, promessa” in albanese) del destino, diventano ribellione luciferina di un essere privo dell’identità originaria, reietto del sacro (come nel sogno autobiografico narrato in “Spine nere” nella raccolta omonima). La ribellione a ciò che dovrebbe garantire un senso incomprensibile pietrifica l’uomo e il poeta Hajdari in un mondo di sasso non meno di quello reificato di Zanzotto. Più ancora della reificazione di Sbarbaro e di quella da lui ripresa di Montale, Hajdari immobilizza il mondo in mura secche, fontane che non hanno più sete (“Fiume tu devi raccontare” in Stigmate,cit.): il mondo è suo specchio, è muro (“Appesi ai chiodi” in Maldiluna, cit.); il tempo perde ogni connotazione di misura scivolando in una dimensione immutabile, ciclica, irrazionale, mitologica (“Ricorda i tuoi giorni” in Stigmate, cit.): quasi un nesso occidentale ed orientale in bilico tra Itaca ed una avveduta riedizione mesoorientale della Bibbia, finanche in una rilettura del Gilgamesh, specie nella simbologia della muta del serpente o della incompiutezza della vita e della morte (“Appartengo ad un popolo” e “Il mio corpo trema” in Stigmate,cit.). Echi mallarmeiani e montaliani (“Io sono con le mie stigmate” in Stigmate,cit.) esplodono nelle nuvole di ceneri talvolta simili ai resti di fuochi purificatori o ultima traccia di olocausti più nichilisti di ogni dottrina pensabile; e – su tutto – un senso della neve come congelamento della fonte di ogni vita che pare scavalcare ogni distanza e sposare, dalla penombra della stanza umida e vuota dai cumuli di libri sparsi in terra nella quale il poeta scrive e condivide il vino con la sua ossessione di poesia, la neve della Beltà zanzottiana (“Sono uomo di frontiera” in Stigmate, cit.); una ipotesi di realtà a cui nessuna lingua è sufficiente perché nessun pensiero è mai sembrato poterne arginare la vastità di sintesi.
Questa Natura, reificazione della poesia; e questa poesia, figura della malattia che consuma (“E’ struggente la memoria” in Maldiluna, cit.) sono le identità del ricordo (“Lotto con il buio e il freddo che avanzano” in Maldiluna, cit.): ricordo – come appunto si diceva poc’anzi – la cui inafferrabilità e la cui inattuabilità avvicina ancora fortemente e nuovamente ad un’illusione leopardiana, o ad un tempo mitico perduto di rilkiana memoria, quasi in una inesorabilità (orfica) di primavera (“Come gli ultimi tuoni d’autunno” in Maldiluna, cit.) in cui l’unico, disperato, nesso di senso nella nebbia insondabile di ciò che ci circonda, è il mistero dell’Altro (“Un cielo inospitale copre il tuo volto” e “Se mi riconosco solo nei tuoi occhi mi riconosco” in Maldiluna, cit.) passando per quella medianità del Corpo/Natura che lo rende Opera, da incidere e sacrificare (“Ti avevo detto che il libro più bello” in Maldiluna, cit.) in un’orfica dispersione del sacrificio estremo che è, in questo atto di estrema resistenza, l’Affronto della Poesia.
