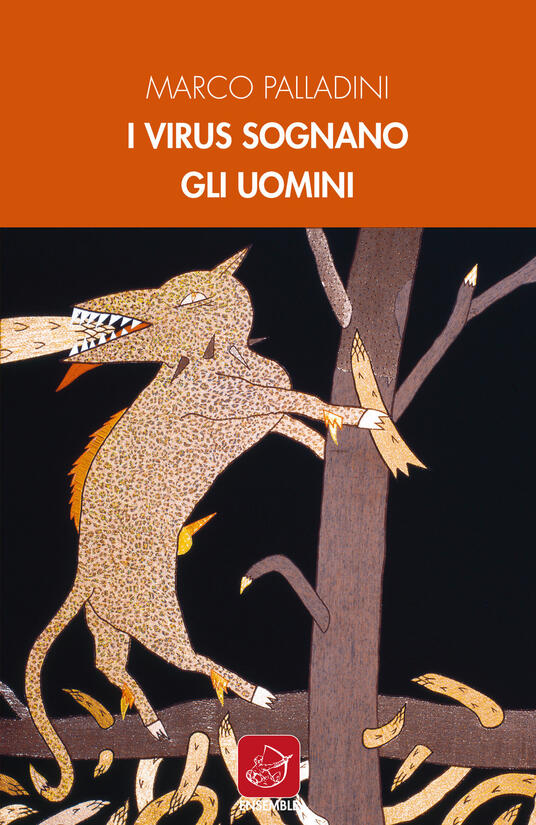«Se la letteratura non perde il suo potere sovversivo»
Recensione di «I virus sognano gli uomini» (Ensemble, 2021) di Marco Palladini. Articolo di di Simone Rebora.
Confrontarsi con il soggetto della pandemia da Coronavirus, al giorno d’oggi, è tanto cliché quanto avventura, tanto sfida quanto certezza. Lo fa Marco Palladini nel suo ultimo libro, I virus sognano gli uomini (Ensemble, 2020) che si propone da subito (e come potrebbe essere altrimenti?) sul versante della sfida, come riflessione sulla possibilità stessa di fare letteratura in tempi così strani e oscuri. La dimensione del cliché e della certezza, però, non è affatto ripudiata in questo iper- (o anti-) romanzo. Al contrario, nella costituzione stessa della sfida essa diventa elemento fondante, riconoscendo come una fuga totale sui canali della pura sperimentazione, o uno sfratto del reale entro una iper- (o anti-) realtà, partano già perdenti nella loro avventura. Perché tutto quel sovraccarico di noia e squallore che ha caratterizzato (e che ancora e ancor più caratterizza) questo periodo storico deve essere trangugiato intero e masticato tutto per poterlo almeno in parte digerire.
Lo si nota sfogliando pagine all’apparenza tutte uguali, dove l’anaforico incipit di ogni paragrafo (“In quei giorni”, soggetto, verbo all’imperfetto…) diviene mantra ironico e sardonico, quasi conscio pungolo alla pazienza del lettore, il quale non può trovare facile via d’uscita dal reale in una letteratura che vuole farsi strumento d’azione sul reale. E così, al piano più alto della strutturazione narrativa, troviamo la vuotezza e ripetitività dei giorni del lockdown, vissuto (almeno da coloro che evitarono il confronto diretto con il Virus) come momento di sospensione della vita attiva, sostituita dalla “bolla” dell’auto-isolamento. Su un piano leggermente più basso, diffuso quasi in ogni parte del libro, troviamo poi un atteggiamento quasi da antologista, che raccoglie ed elenca tutte le stranezze, brutture e curiosità di quei giorni (affatto) tutti uguali. Il quadro qui si complica rapidamente, a raffigurare quella mole di informazioni, timori, orrori e paranoie che rapidamente sommergono l’isolato. Palladini non esita a spingere il più possibile sull’acceleratore, incanalando pagine di elenchi i più strani e stranianti, che letteralmente tolgono respiro e spazio alla lettura, costretta spesso a un confronto arduo con il testo.
Ma l’obiettivo di fondo, ovviamente, non è quello di tediare o sfinire il lettore. Tedio e sfinimento non sono altro che il materiale necessario su cui costruire un impianto narrativo che riscatti la letteratura dal confronto con il Virus; sono le argille da modellare per dare forma a qualcosa che potremmo infine definire “romanzo”. E non a caso è proprio da questi momenti che sbocciano le pagine più elevate. Come quando un paragrafo all’apparenza caotico e frammentario (“Come dare torto ad Heinrich Heine”, p. 82) si risolve in un crescendo immersivo e a perdifiato; o quando da un gioco casuale e ripetitivo (“per micro-epifanie poetiche proposte in pillole”, p. 105) sorgono esercizi combinatori quasi memori del Calvino dei Destini incrociati. Insomma, sembra proprio questa la sfida raccolta da Palladini: lavorare sui tempi del Virus per costruire nuovi ritmi, facendo del grigiore e della ripetizione una nuova scintilla di vita. Perché sotto questo piano di apparente grigiore, raggiunta la superficie più scabra del romanzo, troviamo guizzi di vitalità a tratti soverchiante, registrati spesso “in presa diretta” riportando di volta in volta “frammenti di post” (p. 31), “minuzie stradarole” (p. 101) e quant’altro si presenti all’attenzione. Il tutto anche rinunciando alla sperimentazione linguistica e stilistica, semplicemente lasciando che il mondo si parli da solo, per rivelarsi spesso ben più strano di ogni finzione.
Definire quest’opera “romanzo” è poi scelta in parte discutibile, ma mai del tutto negata. Si distinguono quindi pagine dal saggismo più schietto e quasi “da manuale” (“Già lo scrittore Thomas Pynchon […] aveva spiegato”, p. 13; “Uno scenario […] che richiamava immediatamente il romanzo The Road di Cormac McCarthy”, p. 23), che però mai prendono il sopravvento sui molti dialoghi (dal taglio spesso assai “teatralizzato”) e soprattutto sui molti incontri che costellano le più astratte riflessioni e i più sfrenati ragionamenti. Incontri umani che sono infine il collante di questo romanzo, scritto appunto in un periodo di isolamento forzato, ma teso quanto mai al confronto/scontro con l’altro, per quanto lontano, diverso, o smaterializzato sullo schermo di un computer. Sul piano diegetico, inoltre, non si può negare la presenza di un percorso narrativo, che anzi si consolida sempre più attraverso le pagine del libro (con il tasso di “narratività” che cresce esponenzialmente nella seconda metà). Ma la definizione di “romanzo” è, come detto, assai instabile e spesso consciamente minata alle fondamenta. La narrazione stessa risente di questa intenzione nel suo farsi spesso incerta e instabile, soprattutto nelle pagine finali che vedono una paradossale (e quasi pynchoniana) scomparsa e riapparizione del protagonista. Non è quindi possibile collocare le vicende in un luogo preciso, molti nomi mancano o suonano sfacciatamente finzionali, e in particolare tutti i riferimenti concreti alla situazione reale da cui il libro scaturisce vengono a mancare o risultano sottilmente distorti. Non è detto insomma che il Contagio di cui si parla sia effettivamente quello della pandemia iniziata nel 2020, o non una sua trasposizione distopico-fantascientifica, come gli echi da Philip Dick del titolo (dove i Virus si sostituiscono agli Androidi) sembrano suggerire.
A rafforzare la natura anti-romanzesca di questo romanzo ci pensa poi l’elemento più distintivo della scrittura di Palladini: uno stile giocoso e giocosamente sopra le righe, nel quale però il gioco si fa subito serio e la parola parlata (che ci parla) si fa guida primaria per il senso. Ci si diverte quindi a leggere passaggi dove la voce del poeta/performer si impone su quella dello scrittore (“in risicati e più che affollati seminterrati”, p. 15; “Storie struggenti e, anche, lacrimogene su anziani credenti e/o sacerdoti cadenti portati via in un amen dal Contagio, per la serie: dall’oratorio all’obitorio”, p. 74), ma si scopre presto come certe connessioni ritmiche o rimiche abbiano in sé stesse il valore della rivelazione (come “il nesso epidemia-epidermia”, p. 113). Fulcro di questa creatività linguistica è poi il protagonista stesso del romanzo, Lafcadio, il cui nome (spiccatamente gidiano) presto diventa “dio Lafca”, quasi a premonire il lettore sulla sua futura sparizione/trasfigurazione. Lafcadio si rivela straripante alter-ego dello scrittore, incarnandone la scrittura più che la persona, con avventure (tanto del corpo quanto del pensiero) che sembrano raffigurare le peripezie della letteratura stessa di fronte al leviatano del Contagio. Forse sconfitta, infine, ma certo capace di tramutare anche questa disfatta in un’occasione per librare la propria voce, come ci suggeriscono quei versi posti proprio al termine del romanzo: “Io però sto nell’antimondo, viruspoietico / e un poco cinico, anche poetopatologico / di certo atipico, ma invero non mai patetico” (p. 134).
Al pari dei dialoghi e degli incontri, ultimo trait d’union per le avventure di dio Lafca è quindi la dimensione del sogno, che emerge più volte facendo breccia nelle sue riflessioni e che si concretizza in due incontri immaginifici, con il padre e con il Virus stesso. Se una chiave esiste per aprire il senso di questo testo, dunque, la si dovrebbe proprio cercare in questi passaggi, che non a caso rappresentano ancora una volta incontri con l’altro vicino/lontano. L’incontro con il Virus, in particolare, è culmine di un percorso conoscitivo che porta come estremo risultato al disconoscimento del sé e della realtà. Disconoscimento che non è però disperato abbandono all’orrore del male o ingenua fiducia in un bene ulteriore, perché il gioco della letteratura è sempre giocato con piena cognizione di causa (riconoscendo per esempio l’ironica natura leopardiana di questo dialogo con il Virus). Lafcadio quindi scompare e riappare tramite e dentro la sua scrittura, intesa sia come testo da leggere (per la moglie che ne paventa la morte), sia come processo creativo (per lui stesso, che si annienta e ritrova in esso). E alla domanda (e a certi timori todoroviani) circa la funzione della letteratura nel mondo attuale, Palladini sembra fornirci la risposta più diretta e al contempo elusiva: sconfitta di fronte al Virus, incapace di cambiare il mondo alle radici, la letteratura non perde però il suo potere sovversivo, capace di rivelarci quanto concetti come “bene” e “realtà” siano affatto stabili e stabiliti, ma necessitino di un continuo ripensamento e messa in discussione per sopravvivere a stravolgimenti come quello recentemente vissuto dalla comunità globale.
Il volume I virus sognano gli uomini è chiuso da una estesa Postfazione di Plinio Perilli, che merita una nota a parte per la sua natura (ancora una volta) dialogica, impostata in forma di lettera all’autore e soprattutto strutturata tramite un alternarsi di brani del romanzo e libere riflessioni critiche. Punto centrale dei ragionamenti di Perilli è se la letteratura possa sopravvivere in questo periodo storico così drammaticamente imprevisto. Con questo libro, Marco Palladini ci ha mostrato come una risposta positiva è possibile, ma solo laddove resti ancora e sempre quel coraggio per la scrittura di “mettersi in gioco”, costi quel che costi e senza temere il fallimento.