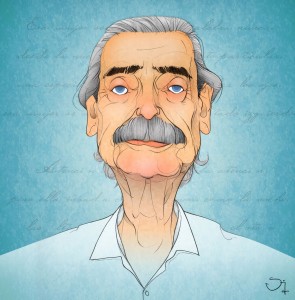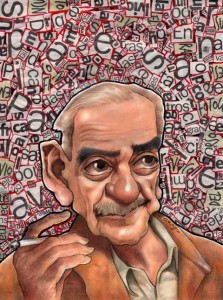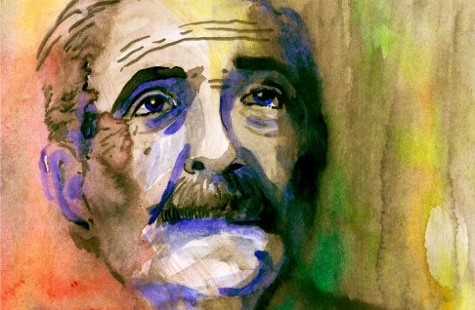
Poesia / Appunti sull’ultimo Gelman in traduzione italiana # 2
Una poesia, una lingua-convenzione quindi, capace di trovare una propria efficacia solamente in un reciproco patto ermeneutico di tolleranza dell’innaturalità.
Non è mistero infatti che non esista lingua lì dove non vi sia o vi sia stata comunità linguistica: ma se l’uscita dalla propria esperienza linguistica naturale è artificio creativo che lega e chiama un mondo trasversale di sodale fondazione e fruizione del vero, questo metalinguaggio appunto rifonda il mondo in una finzione di realtà che per questo appunto ne smaterializza anche quelle che apparirebbero essere le più salde corrispondenze morfo-semantiche.
Leggiamo ancora dalla stessa raccolta, La chiave del gas:
[…]
la moglie del poeta
è condannata al poeta, a quel tipo
[…] [ch]e finge
di domandare per sapere
quando in realtà gli importa solo di domandare
ciò che non ha risposta.
E ancora estraendo da Valer la pena:
Poesia
La tua voce
interrompe il mondo
e gli da un’altra parola. Ora gira
fra i silenzi del sole. Ha in sé
il mare e la tua idea del mare
è più bella del mare. […]
O anche, in Come? (ivi), che per la sua densità e struggente bellezza riporto per intero:
Come sa Andrea che la poesia non ha corpo, non ha cuore e
nel suo alito di bimba avviene o può avvenire
e parla di ciò di cui sempre non parla?
Nella bocca caglia il mondo e alla luce
di passati che Andrea ignora per mai
la sua memoria è una casa nuova dove
altri volti vivranno,
altre aurore, altri pianti.
Meglio così.
Tutto ciò che sprofonda adesso, questo tempo che si dissolve,
saranno per lei pagine ingiallite.
Un giorno saprà che esistettero come lei stessa,
fra l’immaginario e il reale.
Ah vita, quale domani
quando finirai di scrivere!
Quest’esperimento di rifondazione del vero attraverso un linguaggio speculare della realtà, insicuro perché aperto ad ogni dimensione e sviluppo del pensiero, trova rimandi nella necessità intellettuale di Gelman della fondazione di un meta-mondo, una sorta di Iperuranio della memoria, dove fossilizzare e credere la propria appartenenza al mondo sensibile, umano; e prende fattivamente corpo in sotto, dove appunto Gelman elabora contemporaneamente in spagnolo e in sefardita il suo universo poetico, autoimponendosi un esilio anche Linguistico, figura appunto del grave vulnus umano della privazione della appartenenza civile e sociale alla propria Patria.
Lo straniamento che deriva dalla perdita del proprio vincolo linguistico pare allora capace di dischiudere alcuni luoghi dell’universo poetico di straordinaria vitalità: l’estrema compattezza cerebrale di questa urgenza di senso significato oltre le difficoltà della propria lingua madre, costringe a documenti di sintesi semantica che raggiungono esiti assai alti; quasi realia dell’astrazione, mi sembrano adducibili ad esempio i versi della intensa composizione XVIII da “[…] Sotto” (già citato) che recitano:
“tutto ciò che chiamano terra
è tempo
è attesa di te […]”
in cui c’è una progressiva smaterializzazione del coefficiente nominale cantato: da terra a tempo; da tempo neppure a nome, bensì ad evocazione di nome. Davvero, come poi potremo più cogentemente sottolineare più avanti, vediamo rovesciarsi i termini ma non il senso ultimo di uno dei dettati metaforici per eccellenza del Novecento: penso,oltre che all’uso sinestetico e metaforico dell’immagine, al correlativo oggettivo che tanto ha caratterizzato anche la scrittura di Gelman: si legga, pure tra molte, La seggiola (in Valer la pena, Guanda, 2007; già significativamente apparsa appunto in Italia nella silloge vincitrice del Premio Lerici Nel rovescio del mondo, cit.), e che, per la sua importanza e centralità umana e poetica, riporto per intero:
La seggiola
Il dolore passa freddo fuori
e quasi sfiora l’infinito. Dall’altra parte
c’è una luce senza tregua sopra
una seggiola d’oro con un incavo
dove si accomoda l’infanzia. “Non
ricordarti di me”, diceva,
ma io sempre ricordo.
La seggiola sta nella sala, sola, e vedo che la perdita ha
volontà di ingannarsi e fiorisce
vagamente nell’eccesso.
La porta che si chiude a filo
dell’amore accompagnante è questo,
la porta che si chiude.
Dire farfalla alla farfalla non la fa volare.
In ciò che ci tiene insieme,
ti piango molto, bambina dalle due lune,
una che sorge per cominciare la notte.
Il presente è molto vecchio e
si muove negli intervalli del vivere.
Ripete la guancia che non ti vedo.
È oscura di ciò che accadrà.
Soffre illeggibilmente.
Questa lingua poetica che però accenna senza dire il non tempo della morte come opposizione evoca dunque la memoria: (La desolata luce non ha in Lettera a mia madre, cit.)
La desolata luce non ha
memoria né progetto/ va
ai suoi elenchi di perdite/ non smette
di alludere al cane/ al bimbo/ alla
certezza terribile/ chiama
alle porte del limite/ si immerge
nella placenta di fumo tremulo
che le da furia di esistere/ è
attonita/ estrae
rovine dal suo non essere/ perseguita
la cecità che tutto si trascina
e il suono del sogno
nei quartieri del dolore?
la terra rotta del disastro?
e sceglie il non luogo del tempo inabitato della lontananza astorica e prestorica perché metastorica nei cenni, ad esempio, ai poeti dell’opposizione e del canto lirico del passato latino: (Accade in Valer la pena, cit.)
[…]
Cade la mia lingua, come quella di Catullo,
nella sua doppia notte di desiderio
[…]
tanto quanto europeo: ricorderemo qui Hoelderlin (in Differenze,Valer la pena, cit.) e soprattutto Rilke, nel memorabile dittico in Poeti, da Valer la pena, cit.:
[…]
Rainer no. Lui domandava
a chi mai appartenesse quello che non è di nessuno.
[…]
Quando, poi, Gelman si pone tra le pieghe dell’allora giovane gigante della futura cultura d’Europa, Salomon Ibn Gabiron e vi (in)scrive versi come:
“[…]mi lasciò/ se ne andò al cielo
la donna dalla bellissima gola avvolta in una collana
ha labbra dolcissime
ma lei è amara […]”
(La perfida in “Com/posizioni”, cit.)
dando prova di questa capacità generativa dell’immagine come specchio dell’intelletto, non mi pare ci sia concesso di prescindere dalla eco che spande concentrica dai versi conclusivi della canzone di “la barunessa di Carini” (tratto da Vettori, 1974, 243; canto raccolto nel 1964 a Capaci, dalla voce dell’informatrice Rosaria Pagano), vv16-18:
“[…]ora ch’i morta la vostra signura;
li vermi si la macinu la ula
unni c’è mìsa la bella ulera […]” ?
in cui si narra della fanciulla infedele la cui gola coperta da belle collane è mangiata dai vermi, e quindi – per suo tramite – ai trobadori siciliani (cui certo Salomon Ibn Gabirol fu affine, se non propriamente contiguo) che cantavano, nel canto ritualizzato della donna, l’amara via dell’esilio in una distanza dal proprio oggetto di desiderio talmente vasta da risultare azzerata e pietrificante; e d’altronde non può certo sfuggirci come la donna che Gelman Poeta sottende nei versi appena riportati, in realtà non possa prescindere dallo strumento di sintesi ermeneutica del Novecento occidentale cui già abbiamo fatto cenno: il montaliano-eliottiano correlativo oggettivo, appunto.
Ma di cosa potrebbe essere correlativo oggettivo “la donna dalla bellissima gola avvolta in una collana” di Gelman, se non dell’amara esperienza della Distanza esistenziale del poeta oltre che di quella patita dall’esule?
E come dovremmo poi leggere la distanza se non come segno dell’appartenenza imperfetta? A cosa poi non perfettamente appartiene il Poeta che si vive come carne dell’Esilio, condizione della quale Gelman ci narra tanto diffusamente nella sua poesia da porci nella reale difficoltà di scegliere componimenti definitivamente esemplificativi, ma che io mi tenterò di intercettare ancora in una poesia tratta da Valer la pena, cit.:
Intimità
Sei lì, paese mio? La parola
viene avanti e sbatte contro
il vuoto della sua rivelazione.
Ha le ossa febbricitanti, è
un sogno incerto scritto da nessuno.
Che sporcizia questa mattina.
La bocca è bianca lì
e squarciata il giorno dopo
la sua irreale intimità.
Certamente al proprio Paese non meno che alla propria “Cultura originale” intesa come lingua materna e che con/tiene e com/pone l’esperienza del mondo.
Ci fa luce allora l’inattesa affermazione di un altro poeta del dissidio: Besnik Mustafaj, quando, chiamato a dire della bontà dell’Opera di Gezim Hajdari, suo sodale amico nella Poesia e nella lotta per la libertà della comune Patria, dava questa risposta: “… Gezim [Hajdari], che era già un Poeta ed aveva già scritto Poesia in Albanese, ha trasportato [nella terra dell’Esilio] l’esperienza della Poesia prima che la Parola poetica in un’altra lingua [in Italiano]” (Roma, Palazzo dei Congressi, 9 Dicembre 2012; in occasione della presentazione di B.Mustafaj “La leggenda della mia Nascita”, Ensemble edizioni, 2012): quello stesso Gezim Hajdari che dice di sé: “Sono nato in Europa, di lingua Albanese”, lì dove la lingua è quindi appartenenza, ma non identità.
E così è dato agio alle relative distanze. La lingua di Gelman è qui lunga teoria di parabole esistenziali che – misurandosi con la distanza incolmabile e diacronica dei molti secoli intercorrenti tra lei e Ibn Gabirol, sposa una identità ricostruita e denuncia il patimento del proprio esilio in un alchemico ricongiungimento linguistico, non meno di quando sceglie il crogiolo dell’ebraico saferdita per i suoi esperimenti di sotto (cit.).
In apertura vi scrive infatti in Chiosa l’Autore: “Ho scritto le poesia di dibaxu (sotto) in sefardita, dal 1983 al 1985 . Sono di origine ebrea, ma non sefardita, e suppongo che tutto questo abbia giocato un qualche ruolo. Penso tuttavia che queste poesia siano soprattutto il culmine, o piuttosto lo sfociare, di Citas e Comentarios, due libri che ho composto in pieno esilio, nel 1978 e nel 1979, i cui testi dialogano con il castigliano del XVI secolo. Come se cercare il sostrato di quel castigliano, sostrato a sua volta del nostro, fosse stato la mia ossessione. Come se la solitudine estrema dell’esilio mi spingesse a cercare radici nella lingua, le più profonde ed esiliate della lingua.[…].”
La lingua È dunque l’ossessione, la patria mancata, il luogo della condivisione mancata dell’esperienza; e pure mantiene la sua altezzosa dimensione di sogno di struttura perfettamente atta alla circolarità inter ed intra individuale del proprio sentimento del tempo e della vita. Scrive con incisività mirabile Gelman:
“Dici parole con alberi
hanno foglie che cantano
e uccelli
che uniscono sole
il tuo silenzio
sveglia
le grida
del mondo.” (X, sotto, cit.);
ma anche:
“ciò che mi hai dato
è parola che trema
sulla mano del tempo
aperta per bere
taciturna
è la casa
dove ci baciamo
dentro il sole.” (XII, sotto, cit.);
e poi:
“sei
la mia unica parola
non so
il tuo nome.” (XIII, sotto, cit.);
per culminare in:
“nel tuo candore
fuoriesce il mondo dal mondo
questa felicità è cieca
mi calpesta come un bue.//”(XXIII, sotto, cit.).
L’indubbio dettato metapoetico del testo, si schiude visibile già nella sua doppia dizione di stesura: lo spagnolo e il saferdita, appunto. Ma chi leggesse entrambi questi esercizi di ermeneutica che Gelman condusse grosso modo tra la fine degli anni Settanta e il 1985 in pieno esilio, non potrebbe credo negare di intravvedervi quella forza rituale di dizione dell’esilio dischiusa in un desiderio che travalica il mero dettato linguistico per creare appunto, in questo, l’incunabolo vivo dell’esperienza, della res, la cosa: quindi del reale.
Ci si chiederà poi forse se la meraviglia di questa realtà circolare che appare in trasparenza di affabulazione e d astrazione continua, non voglia anch’essa sottendere alla formazione arabo-israelitica degli autori prescelti e delle tradizioni linguistiche a questi legate: tradizioni delle lingue camito-semitiche, appunto, la cui antica struttura triconsonantica garantisce in modo pressoché inscindibiletra la consonanza tra cosa e pensieri da essa derivati.
Un grande poeta come Yehuda Al Harizi, incarna infatti, pur essendo ebreo, la poesia araba classica non meno che, ad esempio, Abu Nuwas, significamente posto in apertura di “Ri/composizioni”: una poesia fatta di grazia e di una sensibilità semplice e sensuale, che mai prescindono dalle cose perfette della realtà.
Questo atteggiamento, che non possiamo relegare a semplice Ri/composizione estetica del mondo, nasce forse da una rimeditazione mistica dei sensi: e non a caso la sensualità della poesia araba di ogni tempo permea di impreviste ed incessanti incursioni la sensibilità dei più grandi Poeti europei pur non prescindendo dall’esperienza dell’epos che anzi rielabora filtrandola in un elogio della levità dell’esistente che non è certo superficialità; e che altrettanto evidentemente spiega come il pensiero arabo abbia potuto essere il tramite principe del pensiero e della civiltà poetica greca, altra generativa matrice prima della nostra identità, permeandolo di un più mistico ed immanente mistero della conoscenza, che riecheggia poi quelli delle gloriose e millenarie civiltà del Vicino Oriente, dell’Egitto antico, del Mali, non meno che dell’India.
Ma la Lingua originaria di questi canti, scelta poi per la meditazione compositiva di sotto, ed i richiami autorali ad alcuni Profeti biblici, schiudono forse un’intenzione fondativa dell’azione poetica ancor più definitiva: si tratta infatti della Lingua della Parola del Libro che è, per ogni monoteista, la base, il fondamento della realtà condivisa, terrena.
Non sarà forse superfluo allora sottolineare come la lingua ebraica in ogni sua storica elaborazione abbia mantenuto questo distacco dalla lingua della patria politica cui le singole comunità di culto semitico appartenvano, confacendosi a divenire una sorta di lingua franca, un luogo linguistico in cui ricomporre il dramma dell’Esilio cui il popolo ebreo fu condannato.
E per tutte e tre le religioni del Libro, poi, la stessa realtà terrena cui poc’anzi è stato fatto cenno è conseguenza del primo e più secolarmente imperituro, irreversibile degli esilii: la Cacciata dall’Eden:
nella separazione della parola
il padre detta la sua legge/è
incubo che attende morto luce
che mai gli sarà data/ l’altro
da se stesso sono io/ il suo sogno
di cielo che ci copre
come parodia di pietà/ il padre
mantiene promesse che
mai fece/ è chiara
la disoccupazione del vissuto
in tempo/ in ansia/ in pozzo dove
il padre vola
e non bada al tramonto come
se ci fosse vento/
(nella separazione della parola da Lettera a mia madre, cit.)
Il dettato poetico allora, non apparirà essere la chiave di volta di una “ricostruzione” del creato a dimensione umana -nella quale spiri quindi lo pneuma divino tanto quanto la irrisolta dimensione umana, la disoccupazione del vissuto appunto- della Perfezione/Unità/Identità Originaria?
E questo titanico sforzo di Prometeo del Poeta, divaricato tra l’ambizione e la dannazione che consegue la certezza dell’irrealizzabilità – quindi la nuova eiezione figlia di superbia – tanto alto in premessa, si incarna in un’ottica (mai) totalmente laica:
[…]/ ci scrivemmo poco in questi anni d’esilio
è anche certo che prima ci parlammo poco
fin da molto piccola, la tua creatura si ribellò a
te/ al tuo amore tanto stretto/ così mangiai rabbia e
tristezza/ non mi mettesti mai le mani addosso per
picchiare/ picchiavi con la tua anima/ stranamente
eravamo uniti/[…]
(Lettera a mia madre, in Lettera a mia madre Guanda, 1999)
e spinge Gelman ad inseguire il segno di un senso perduto, appunto, in quello che lui stesso ha icasticamente definito “Il Rovescio del Mondo” :
[…]
La primavera vive senza pensare,
ma io non sono la primavera,
racconto ossa e sangue del sogno che verrà.
Noi pure sognammo del sangue che verrà.Nel rovescio del mondo cresce il cosmo
e Gerarda sta lì,
dove il nostro dolore sarà nulla.
(Certezze, in Valer la pena, cit.)
Se dunque l’Esilio è la madre e il padre di tutte le esperienze umane, tanto che anche la nascita da madre è esilio della nostra carne, la Parola della Legge e della Verità si rovescia in un’ ambizione tutta creaturale di fondazione che Vittorio Sereni definì “Strumenti Umani”.
Poesia, dunque, come figura dell’Esilio privato ed esistenziale del Poeta-Esule; ed Esilio come perdita di una perfezione persa ab origine e in absentia ritentata nella ri/fondazione della realtà.
Esilio e Poesia come germi del mondo avvertito e percepito: doppia entrata all’unica matrice di una Identità condivisa nell’innovazione della realtà, non meno che nella Parola, che accoglie come in quella accolta.
È impossibile a questo punto non ripensare all’affermazione di Besnik Mustafaj e non constatare ad un tempo, come l’esperienza di questa realtà fuggita e ricostruita per il mezzo “altro” della lingua-ospite ricalchi una compattezza dell’oggetto cantato e del soggetto poetante che si fondono in una potenza espressiva ricca di evocazioni reificate che come pietre fulgide riecheggiano di senso percepito la dizione poetica.
Ed ecco che, per altra via, riemerge ancora il modo circolare del dettato poetico Novecentesco più vero: quello, in Italia, di Sbarbaro, di Caproni, di Rebora, di Montale, Zanzotto, o Pasolini: una Parola che dice il Mondo oltre ogni indugio, e dicendolo per solidamente vero lo astrae, creando nell’esperienza poetica, l’Esilio di sensi e segni; ed in questa stessa esperienza fondando la Patria nuova della sua estrema Ri/composizione.